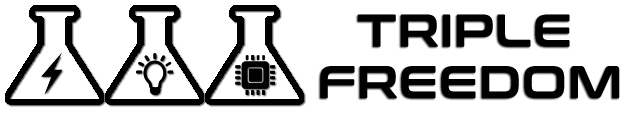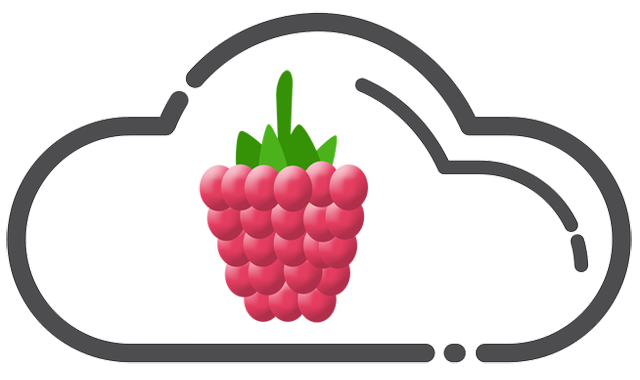Poteri dell’amministratore di condominio
25 Novembre 2012affidamento condiviso: le decisioni di maggior interesse
26 Novembre 2012Affidamento condiviso: la potestà genitoriale
Con la l. 54/2006 il legislatore ha previsto che entrambi i genitori continuino ad esercitare la potestà sui figli.
Quella che in passato era l’eccezione, è divenuta oggi la regola,[1] e costituisce una delle enunciazioni di principio di maggiore importanza della nuova legge.
Occorre tuttavia prestare attenzione alla lettura della norma, che a parere di molti è stata formulata in modo impreciso.
Il riconoscimento della spettanza ad ambedue i genitori dell’esercizio della potestà sembrerebbe interpretarsi nel senso dell’attribuzione a entrambi, in via paritaria e di comune accordo, dell’esercizio di tutte le prerogative inerenti al potestà compresa l’adozione di tutte le decisioni relative alla quotidianità del figlio. Purtuttavia, la regola opposta sembra potersi ricavare laddove la norma prevede che le decisioni di maggior interesse per i figli debbano essere prese di comune accordo: ciò pare sottendere che le decisioni meno importanti possano essere prese separatamente.
Quindi, qual è la regola?
Deve ritenersi corretto che l’esercizio congiunto della potestà riguardi anche le questioni di carattere routinario, salvo la possibilità per il giudice, ove lo ritenga opportuno o necessario, di attribuire a entrambi i genitori il potere di assumere disgiuntamente le decisioni che riguardano la quotidianità del minore, ovviamente nel rispetto delle regole generali di educazione concordate nel progetto di affidamento condiviso, o in alternativa e comunque, nel rispetto delle rispettive sfere di autonomia e competenza.
Indispensabile è partire dalla considerazione che il potere-dovere educativo di allevamento e di cura spettante ai genitori costituisce un munus (dovere) da esercitare nel rispetto delle inclinazioni e aspirazioni della prole, e non più, come in passato, l’espressione di un potere di comando e di correzione, a fronte del quale il figlio si poneva in una posizione di soggezione.
La potestà genitoriale è quindi prima di tutto un dovere, o meglio una responsabilità, come sancito anche a livello comunitario.
Partendo da questo principio, è facile concludere che, anche quando i genitori non sono in grado di trovare accordi sulle decisioni da assumersi nell’interesse della prole, non di meno essi conservano il dovere di entrambi educare istruire e prendersi cura dei figli
In altri termini, l’affermazione di condivisione della potestà non riguarda solo il potere dei genitori di assumere le decisioni riguardanti la vita dei figli e di attuare l’indirizzo educativo: essa inerisce piuttosto i diritti di cui i figli sono titolari nei confronti dei propri genitori, tra i quali, in primo luogo, la pretesa di ricevere da entrambi i genitori quanto necessario al proprio sereno e equilibrato sviluppo psicofisico , e alla realizzazione delle proprie aspirazioni di vita
Pertanto tra le aspettative legittime del figlio vi è quella di ricevere tale apporto da entrambi i genitori.
Per concludere, la più ragionevole lettura dell’art. 155 3° co è la seguente: posto che finalità della norma è la collaborazione, il rispetto reciproco, la riduzione dei motivi di contrasto nell’interesse del benessere dei figli, entrambi i genitori continuano a esercitare la potestà insieme, ma separatamente, continuando a occuparsi della prole secondo linee educative e scelte di indirizzo in linea di massima concordate, come quando avveniva durante la convivenza. In altri termini, ciascun genitore deve continuare a esserlo con l’altro ma in modo diviso.
Fermo restando che, se i genitori non riescono a trovare accordo su questioni di piccola importanza, il giudice potrà stabilire che essi le assumano separatamente, ad esempio optando per una suddivisione meramente temporale dell’esercizio o per la distribuzione di incarichi differenziati.
2 – l’autorizzazione all’esercizio disgiunto della potestà relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione
Come anzidetto, l’art. 155 3° co. attribuisce al Giudice la possibilità di stabilire, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la potestà separatamente.
La previsione consente al Giudice – qualora i genitori non siano in grado di trovare accordi sulle questioni inerenti la vita quotidiana del figlio, o comunque di minore importanza – di attribuire a ciascuno il potere di assumere separatamente tali decisioni evitando così motivi di contrasto e aumento di conflittualità; oppure nel caso in cui la lontananza renda più gravosa la gestione comune. In pratica, nei tempi di permanenza presso di sé, il Giudice attribuisce al genitore di determinarsi liberamente senza dover consultare l’altro.
Nonostante le critiche avanzate da certa dottrina, l’alinea in questione consente al Giudice – in presenza di talune circostanze di fatto esse stesse oggetto di esame ed opportuna valutazione – di effettuare aggiustamenti della regola base, che viceversa potrebbero ritenersi incompatibili se fosse richiesta una applicazione rigida del principio dell’esercizio di potestà congiunta.
[1] la legge prevedeva titolarità congiunta ed esercizio separato, e, nella pratica, unica manifestazione della persistenza in capo al genitore non affidatario dell’esercizio della potestà era rappresentato dal potere di vigilare sul comportamento del genitore affidatario e di reagire nei confronti delle decisioni pregiudizievoli prese da quest’ultimo